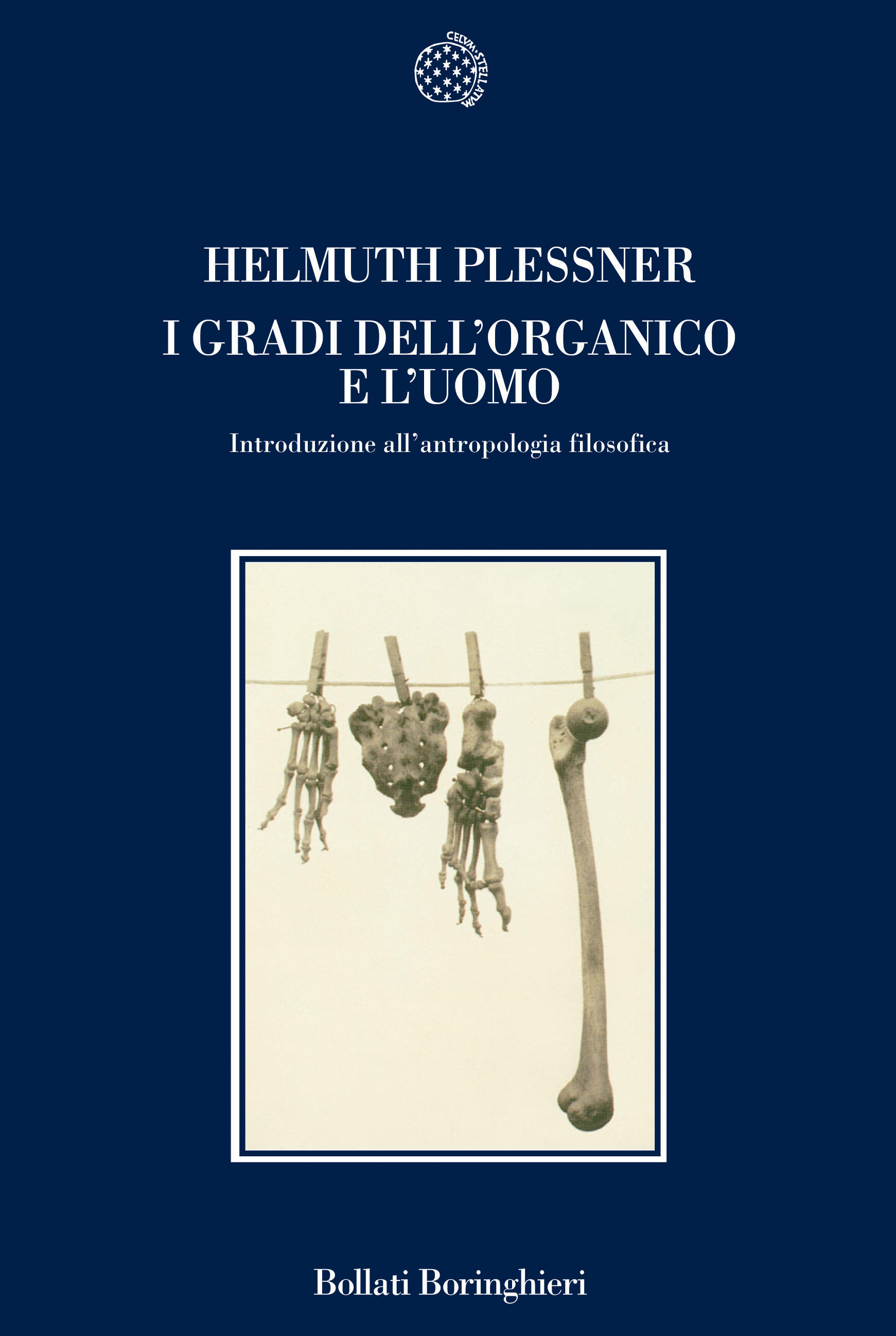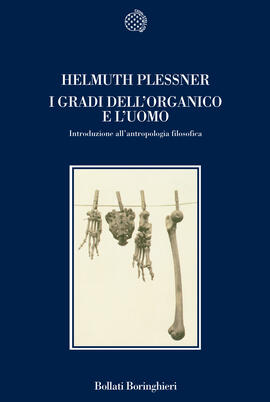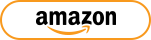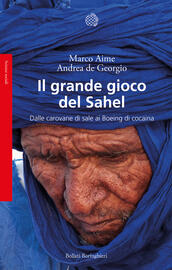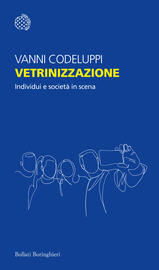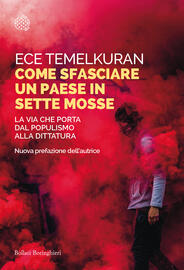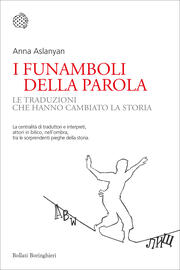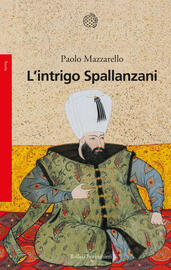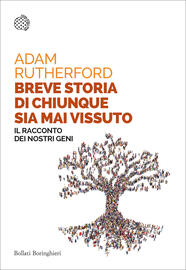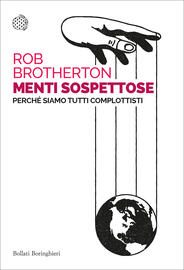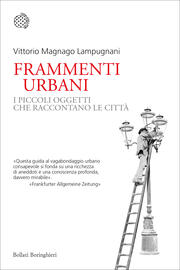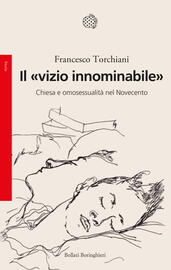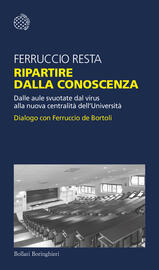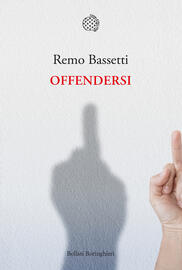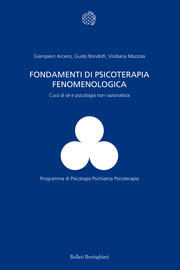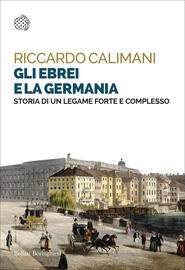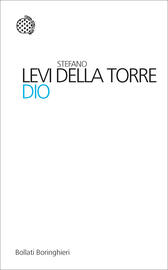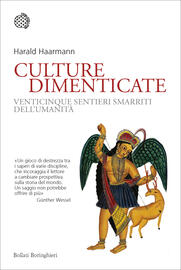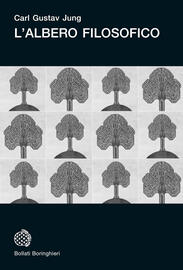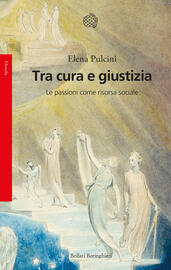I gradi dell’organico e l’uomo
Introduzione all'antropologia filosofica
Pubblicata nel 1928, un anno dopo Essere e tempo di Heidegger, l’opera capitale di Plessner – tradotta ora per la prima volta in italiano – patì marginalità e silenzio da parte di un dibattito teoretico in gran parte assorbito dalla filosofia Heideggeriana. Da essa la distanziava l’idea di fondo che l’indagine dell’”essere extraumano” non debba “essere preceduta necessariamente da un’analitica esistenziale dell’uomo”. L’antropologia filosofica di Plessner, che negli ultimi decenni e stata accolta tra i vertici del pensiero del Novecento, nega il pervicace soggettivismo secondo il quale “colui che pone le questioni filosofiche e il prossimo esistenziale di se stesso” e parte dal presupposto che l’uomo non sia “né il più prossimo ne il più lontano da se stesso”. Una condizione eccentrica all’interno del vivente che sottrae l’essere umano all’univocità biologica del comportamento e determina la sua forma di vita come essenzialmente artificiale, aperta alla plurivocità della seconda natura. La domanda, di tono kantiano, sulle sue condizioni di possibilità implica un allargamento della prospettiva e conduce a esiti originali, a una sorta di cosmologia dell’organico in generale, ritenuta indispensabile a ogni teoria distintiva dell’esperienza umana.